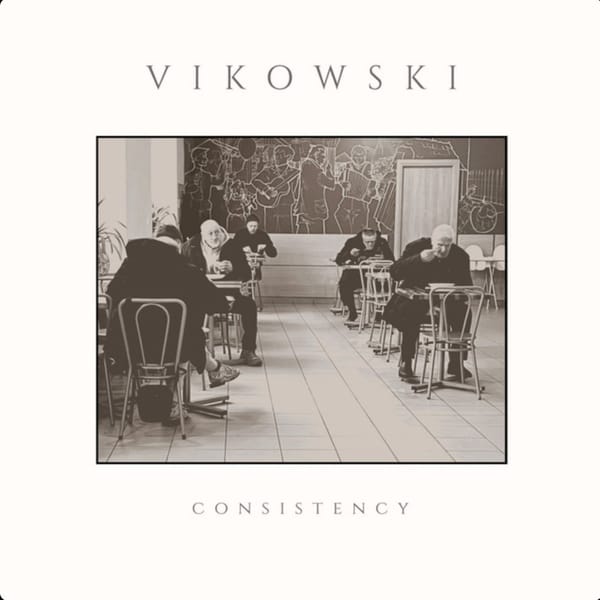Il silenzio degli artisti è un atto politico?

È cronaca recente la notizia che la campagna BDS, il movimento a guida palestinese per l'interdizione e le sanzioni contro Israele, abbia diramato un comunicato invitando al boicottaggio del tour europeo dei Radiohead, che toccherà peraltro anche le nostre sponde con quattro date a Bologna. Sorvoleremo in questa sede, rimandando all'oceanica trattatistica disponibile online, sulle ragioni che hanno portato la band a questa discesa negli inferi mediatici, tra dichiarazioni cerchiobottiste e collaborazioni con artisti israeliani. Ci basti qui ricordare in breve lo screzio dello scorso ottobre durante il live australiano tra Thom Yorke e il manifestante filo-palestinese, da mesi virale sui social e capace di generare polarizzazioni ideologiche nella sezione commenti ben più efferate di quelle andate in scena al tempo della Guerra dei Trent'anni.
"Quel silenzio, che era il tentativo di mostrare rispetto per chi sta soffrendo e per chi è morto, e non banalizzare tutto con poche parole, ha spinto alcuni gruppi opportunisti di usare l’intimidazione e la diffamazione per riempirlo. Mi rammarico di aver concesso loro questa possibilità. (...) La caccia alle streghe sui social da entrambe le parti mette sotto pressione gli artisti e chiunque capiti a tiro quella settimana affinché facciano dichiarazioni. Questo non fa altro che aumentare la tensione, la paura e l’estrema semplificazione di problemi complessi che meriterebbero un vero dibattito faccia a faccia tra persone che vogliono sinceramente che i massacri finiscano e si trovi una qualche forma di comprensione."
Si è maliziato molto sulla reticenza della band, su Johnny Greenwood e i rapporti con Israele ma, aprendo la focale, la domanda è: perchè il silenzio degli artisti non viene accettato? E no, la questione non riguarda meramente un dibattito talmente cruciale come le dinamiche geopolitiche del nostro tempo. Guardando già solo in casa nostra, sull'eredità di Lucio Battisti gravano ancora gli strascichi di una vulgata che l'avrebbe voluto cripto-fascista per non essersi mai davvero esposto sulle lotte negli anni della contestazione; qualche anno fa toccò a un'icona politicamente insignificante come Laura Pausini subire una discreta shitstorm per essersi rifiutata di intonare Bella Ciao nel corso di una trasmissione spagnola, "non volendo essere strumentalizzata da altri per propaganda politica". Come del resto, a loro modo, un certo sospetto lo attirarono anche gli Stadio nel Sanremo 2016, rifiutando i simboli rainbow durante la loro esibizione e attirandosi così persino le simpatie di un Adinolfi (l'impasse dovette rivelarsi davvero pericoloso), prima di ripiegare in corner con un dietrofront tanto acrobatico quanto efficace. La lista sarebbe lunghissima, ma la questione è: ha davvero un significato l'omissione di opinione?
Nella percezione comune e dalla notte dei tempi, il ruolo dell'artista riveste un peso specifico diverso rispetto a quello di qualsiasi altro intrattenitore, assumendo presso le fanbase più esaltate contorni messianici dalle responsabilità perfino morali. Neanche a dirlo, con l'avvento dei social questa dinamica è sconfinata in schemi tossici da inquisizione spagnola, confluendo in due principali forme degenerative: da un lato carriere letteralmente consacrate, al di là di ogni merito artistico, dall'adesione strumentale alle cause socio-politiche del momento; dall'altro corse spasmodiche verso l'ostentazione di adesione (per lo più superficiale) a queste stesse in previsione di possibili indagini della Psicopolizia. La smisurata risonanza raggiunta dai canali social di artisti di punta cozza rumorosamente con il concetto di neutralità; il silenzio si fa assenso, venendo percepito come un tacito sostegno allo status quo; la riluttanza diventa a suo modo cripto-fascismo. La questione si è aggravata drammaticamente alla luce dell'attuale situazione geopolitica; esporsi diventa un atto dall'impellenza del tutto eccezionale. L'ha provato sulla sua pelle Paolo Sorrentino in questi giorni al Festival di Venezia. Tentando goffamente di rimediare alla sua fuga davanti alle telecamere, Paolo ha palesato, paradossalmente e ancor di più alla luce del giorno, la sola premura nel difendere la sua posizione, ritrovatasi al centro di interessi economici giganteschi (ndr. il suo ultimo film è distribuito da Mubi, piattaforma sostenuta da Sequoia Capital, che investe in società israeliane legate al settore militare).
Tagliare i rapporti artistici non è mai utile, soprattutto per il portafoglio di chi nel settore cultura ci campa. Ne sa qualcosa Woody Allen che, pur condannando irremovibilmente l'operato di Putin, si è detto disponibile a girare un film in Russia, accogliendo l'invito del Moscow International Film Week e venendo per questo silurato dal Ministero degli Affari Esteri ucraino. Il disimpegno degli addetti alla cultura non è mai stato possibile: il silenzio è indifferenza e "scrivere" è già di per sè fare politica. Il disimpegno di oggi è una fuga dalla realtà in cui l'intellettuale non fugge però dai riflettori, dalle sue rendite e dalla comodità del profitto. Il modello del San Girolamo nel deserto, ritiratosi a vita privata per studiare senza esporsi, urta platealmente con l'esigenza di lucrare sul sistema mediatico. Si crea così, per i firmatari e non del manifesto X, una situazione contraddittoria: artisti da un po' fuori dai radar (se non finiti proprio nel dimenticatoio) che ritrovano validazione presso il pubblico; icone dello showbiz che (consapevolmente o superficialmente) chiamano la massa alle armi, venendo elevate da questa agli altari; dissidenti malcelati che, facendo parlare di sè inizialmente in termini censorei, si guadagnano alla lunga un fascino maudit. Chi mangia davvero con la guerra non è l'industria delle armi, ma quella della cultura.