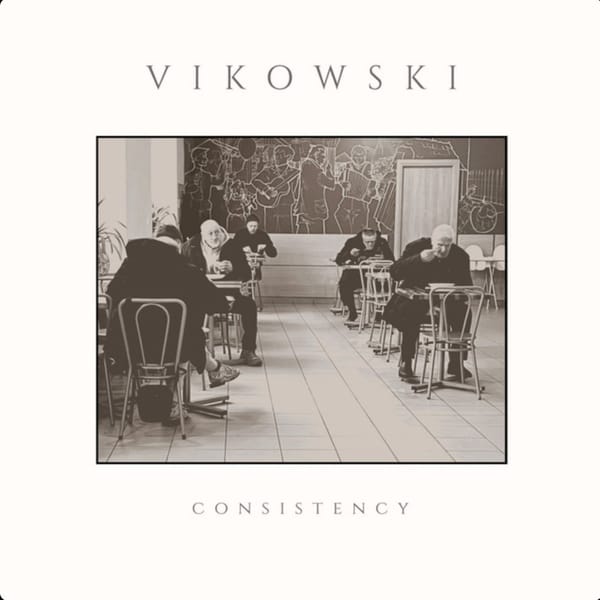L'addio di Roberta ai Verdena lascia un vuoto dietro di sè. E no, non solo generazionale

Oggi il tema della "rappresentanza" o dell' "inclusione", soprattutto sponda cinema, divide il dibattito pubblico fino a una polarizzazione tribalistica a tratti quasi ingiustificabile. È bene ricordare però, come negli anni '90, soprattutto in ambito musicale, il discorso fosse già avviato senza particolari polemiche o strumentalizzazioni mediatiche montate ad arte. Musicisti come James Iha o Mike Shinoda, per quanto connotati etnicamente, non venivano percepiti come scelte inclusive o politiche. D'arcy Wretzky e Kim Gordon costituivano sì, un attacco latente al sessismo del mainstream e alle sexy frontgirl del pop, ma mai una critica ideologicamente esibita o uno shock value. Esistevano già, certo, band femminili come le Go-Go’s, le Bikini Kill o le Hole, ma furono soprattutto Kim Deal, Bilinda Butcher o Tina Weymouth, che esibendosi fianco a fianco ai loro "fratelli", indirizzarono una generazione di ragazze verso un settore fino ad allora profondamente maschile, tutt'a un tratto accessibile per propri meriti tecnici e umani, senza tokenismi, bypass politici o quote rose. In Italia, invece, lo sappiamo tutti, arriviamo sempre in ritardo sulle ondate, un po' per il rapporto fisiologico tra centro e periferia (del mondo), un po' per quel connaturato conservatorismo che porta l'italiota medio a guardare con sospetto tutto ciò che devia di qualche centimetro dalle istruzioni impartitegli sin da bambino per la lettura del rosario.
Del tutto indicativo ripensare quindi oggi a quella clamorosa bolla che fu l'alt rock italiano (già di per sè un riflesso fuori tempo massimo della recrudescenza underground dei '90s americani) e ai Verdena come la risposta peninsulare (anche se certamente non programmata o calcolata) al gender inclusion nel mondo musicale. Da noi c'erano gli Afterhours, i Marlene Kuntz, CSI e diversi altri a offrire la versione mediterranea della formula rumore&introspezione, ma i bergamaschi avevano qualcosa di più. Quel plus si chiamava Roberta Sammarelli, una musicista dalle doti tecniche e caratteriali fuori dall'ordinario; una personalità, in questo senso, tanto italiana quanto per nulla italiota. Musicista, dunque, prima di tutto; ma per la sua unicità (assieme ad Elisabetta dei Prozac+, Rachele dei Baustelle e pochissime altre) inevitabilmente anche faro, vademecum e speranza per milioni di nostre connazionali senza il cui esempio, magari, avrebbero continuato a convincersi che fare musica qui significasse solo mettere in croce rime con sole, cuore, amore o rifondare i Gazosa. La notizia di ieri, apparsa sui profili social della band e abbattutasi su di noi con la stessa veemenza con cui qui accogliamo solitamente la morte di un pontefice (ossia tra lo sconforto e il meme, anche se nel nostro caso ieri non c'era tanta voglia di scherzare), è che Roberta, dopo quasi 30 anni di connubio, ha deciso di lasciare i Verdena.

La ricezione un po' tiepidina dell'ultimo Volevo Magia ha suggerito a molti la conclusione, anche giustificabile dopo 11 album, che la band avesse ormai già dato il meglio di sè. Ma la questione posta su queste basi si rivela riduttiva e, a prescidere dal magone personale che porta a sentirmi orfano di un sogno adolescenziale, si carica di significati ben più ampi. Sono più di 20 anni che il rock ha abdicato al mainstream a livello globale, e oggi forse avrebbe anche senso parlare di "rappresentanza" dell'underground nel mainstream, prima ancora di inclusione sociale nell'alternative. Figuriamoci in Italia, dove al genere, anche nel suo clou di popolarità, è stato dedicato lo stesso spazio mediatico concesso a Mauro Biglino su Rete 4. Il punto quindi è: in un universo musicale che va ormai senza deviazioni verso la digitalizzazione totale e le icone femminile che dominano le vette delle classifiche rappresentano la quintessenza della viralità danzereccia e della sessualizzazione (talvolta manifesta, talora verniciata di enpowerment, ma in entrambi i casi basata sul puro e bieco marketing), quale futuro per la musica alternativa e per la partecipazione femminile alla stessa?

Mi si verrà a dire quanto sia sciocco illudersi che una singola persona, per quanto forte, sfrontata e iconica come Roberta, potesse farsi carico da sola sulle proprie spalle di un'intera causa e che, del resto, almeno a guardare i numeri, lo stesso "caso Verdena" non sembra aver partorito una schiera così lunga di epigone sulle nostre sponde. Ultima della genealogia, perdonatemi l'accostamento un po' profano, potrebbe considerarsi Victoria dei Måneskin. Ma ecco, ve l'ho anticipato, "un po' profano". Ci ho pensato un attimo e la domanda che mi si è palesata forse apparirà (almeno spero) meno stupida delle premesse di partenza: al netto della diversità di contesto e in soli termini archetipici, avrebbe più senso oggi paragonare la bassista italo-danese a una Kim Gordon o a un'Elodie? Ed eccettuando la rocker di Monteverde alla conquista del globo a suon di dj set, a chi possiamo riferirci nel contesto italiano che possa raccoglierne l'eredità, senza andare a scavare nel circuito ultra-indipendente? Ecco allora che con qualche pennellata, il quadro alla fine pone più domande che risposte e rischia di regalare più disillusione che speranza. E così oggi mi sento un po' come il Salemme che chiedeva la pensione di invalidità civile perchè era fallito il comunismo: gli ideali che sostenevano la mia etica sono falliti, ma io non posso che vivere seguendo meccanicamente quegli stessi ideali, utilizzando un codice di comportamento che questa società non ritiene più valido. Sono orfano di un sogno adolescenziale. Ma cara Roberta, ti siamo grati, comunque, sempre.