Ripensare l'italogaze

Proseguiamo la serie di retrospettive con un capitolo dedicato allo shoegaze italiano, un filone che in Italia non si è ancora concretizzato in un vero e proprio movimento, fatto testimoniato dalla molteplicità di direzioni da esso intraprese nell'arco di tempo che va dalla fine degli anni '2000 al presente. Qui proponiamo una carrellata in ordine cronologico dei lavori più significativi di questa stagione.
(2007) Cosmetic - Sursum Corda

Il 2007 fu per lo shoegaze una sorta di no man's land: la grande stagione del genere, quella ancora in grado di stazionare nei canali principali, si era esaurita da una quindicina d'anni e l'epidemia revival avrebbe invece impiegato ancora un po' prima di divampare. Figurarsi qui in Italia, dove una tradizione gaze praticamente non c'era mai stata prima. Non a caso la band romagnola apre il sipario con un'invocazione alla speranza nei momenti di smarrimento, "In alto i cuori". I Cosmetic emergono, appunto, come una versione italiana e fuori tempo massimo del genere: l'etereità alla Cocteau Twins qui non c'è, la voce è ben distinta. Lo scontro fra le vagonate di fuzz e la sensibilità cantilenata di Bart serve più a sottolineare una suggestione di disagio emotivo che a creare un vera e propria texture. La scrittura è ricercata (si è parlato, goliardicamente ma neanche troppo a torto, di carmenconsoli-gaze) in controtendenza col minimalismo del filone anglosassone, in cui le parole fungevano per lo più da elementi accessori di un pattern armonico. Tra staffilate alla Sonic Youth, sverniciate distorte e una slackery alla J Mascis, i Cosmetic mesmerizzavano gli anni '90, molto in anticipo rispetto al loro comeback estetico. Un po' revenant, un po' profeti, ma senz'altro fondamentali trait d'union, con Sursum Corda riaccesero una tradizione.
(2008) Klimt 1918 - Just in Case We'll Never Meet Again (Soundtrack for the Cassette Generation)

Tanto genuinamente tricolore è l'esordio dei Cosmetic, quanto votato all'afflato internazionale l'avvio di carriera dei romani Klimt 1918, già al loro terzo album dopo un apprezzato lancio nel 2005. Sebbene gli ammiccamenti si inizino a insinuare sin dai titoli (paradigmatica in questo senso Skygazer), le sonorità prettamente dreamy rimangono una componente, per così dire, ausiliare rispetto all'impalcatura generale, consacrata alla grandeur bonovoxiana, tutta cori cristallini e crescendo emotivi. La patina nostalgica pervade l'intero disco a partire dal titolo (il revival vintage delle musicassette è peraltro già in atto da alcuni anni, rendendo oggi questo disco una sorta di capsula del tempo), ma più che alle atmosfere impalpabili di un Souvlaki, l'album dei Klimt si rifà alle coeve produzioni sintetiche e tensive del post-punk revival di inizio 2000 (Editors, Interpol). Il ritorno alle trame chitarristiche a suon di riverberi non si è ancora concretamente codificato in un movimento e il terzo della band capitolina somiglia più a un alt-rock nostrano (non avevo mai fatto caso prima a quanto la linea melodica di The Graduate alludesse a Se Telefonando) con un occhio al trend europeo e l'altro a una reviviscenza degli ascolti adolescenziali.
(2009) Cosmetic - Non Siamo di Qui

Se si può imputare una tara ai primi Cosmetic è quella di non aver realizzato un disco realmente diverso dagli altri. Questo sì, ma la formula è talmente originale per il contesto italiano che a più di 15 anni di distanza, a mio avviso, meriterebbe pure riconsiderazione. E così il sophomore, senza discostarsi di troppi centimetri da Sursum Corda, amplifica le stesse domande: shoegaze? l'ispirazione è evidente, ma gli ingredienti non aderiscono in maniera così palmare come sembrerebbe a primo impatto; Verdena? mentre i bergamaschi rilasciavamo Requiem e lavoravano a Wow, i romagnoli esprimevano un'adultescenza scornata ma presa bene del tutto estranea all'ombrosità dei primi; grunge e stoner? i fuzzoni ci sono, ma più che ai Nirvana o ai Kyuss penso ai riff dei Motorpsycho. Ad ogni modo, anthem da giornata dell'arte come Bolgia Celeste o Nè Noi nè Leandro gli valsero il ticket per il passaggio dalle produzioni indipendenti a una label come La Tempesta. Qualcosa doveva pur significare.
(2012) Cosmetic - Conquiste

"La cura si sente già, lo so che mi sta giovando, anno dopo anno", anche se in realtà all'esterno non sembrano manifestarsi particolari segnali. Il terzo capitolo dei romagnoli non sembra spostare di molto il discorso dai precedenti lavori, sebbene la formula sia stata qui quasi totalmente emendata dagli ultimi sintomi shoegaze in favore di un brillante formato canzone noise pop che ricorda tanto Green Mind dei Dinosaur Jr. Il disco ha alcuni dei momenti più iconici di quegli anni e del repertorio dei Cosmetic (Lenta Conquista, La Fine del Giorno), ma è anche uno dei più manifesti equivoci critici: Conquiste è italogaze shoegaze quanto Around the Fur dei Deftones. Ovviamente questo non è un torto della band e probabilmente neanche un problema degli ascoltatori normali, solo un cruccio per monomaniaci come il sottoscritto.
(2013) Rev Rev Rev - Rev Rev Rev
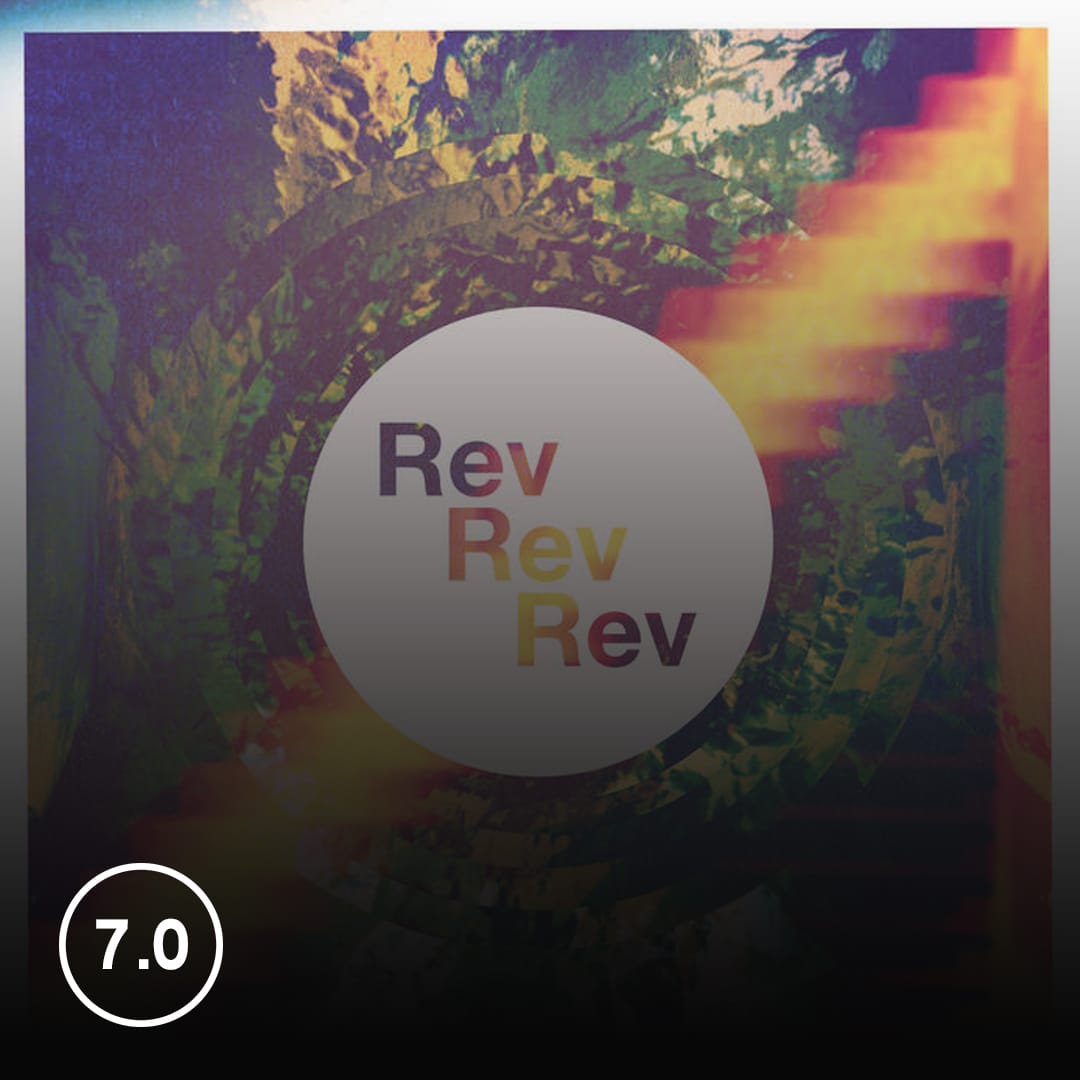
Rev Rev Rev capitolo I è con ogni probabilità il progetto discografico che più si sia mai avvicinato in Italia ai My Bloody Valentine di Isn't Anything. Distorti talmente acidi da non riuscire a distinguere neanche più le plettrate, prolungate detonazioni noise e bassi cupi che si mescolano in un distillato straniante. Il melodismo da onironauti di Loveless non c'è, benchè la band avesse esordito con un EP dal titolo Hypnagogic Visions. Qui, al contrario, c'è poco del sogno e molto dell'incubo: l'indole dell'album è schiettamente votata a un suono perturbante, spaventoso e lontano; le ritmiche e i bassi devono ancora molto al post-punk (teniamolo a mente perchè tornerà spesso nelle produzioni italiane). Il disco esce 9 mesi dopo l'inaspettato ritorno discografico dei loro oracoli, ma non c'è nulla di premeditato: il quartetto modenese guarda alle origini del movimento più che alle sue successive evoluzioni, con un piglio che si potrebbe azzardare a qualificare come archeologico.
(2013) Weird. - Desert Love for Lonely Graves

Il primo atto dei Weird. semina i germi di un'identità già al tempo ben definita, ma che si inquadrerà in una formula tutta peculiare nel loro sophomore (di cui abbiamo già parlato qui in passato). Chitarre spaziose e avvolgenti, ma dal timbro tagliente, quasi verso il surf; canto sofferto, a tratti strascicato, memore di quella stagione post-britpop abitata dalle voci malinconiche di Verve e Doves; piglio splenetico, senza conservare molta speranza. L'impressione è che, più di trovarsi in uno dei viaggi onirici ai limiti del lisergico di Loveless o in un valzer fuori dal tempo e dallo spazio in Just for a Day, qui siamo su una scogliera durante una brulla giornata invernale a cercare correlativi oggettivi tra i nostri malesseri e le onde che si infrangono. Forse il disco complessivamente deve più alla stagione alternative anglosassone di qualche anno prima, che non ai capitoli principali del sussidiario shoegaze. La loro formula avrebbe riscosso poco seguito nella scena, ma connota ancora oggi il loro sound in maniera così distintiva all'interno del contesto italiano da renderli quasi un unicum.
(2016) Rev Rev Rev - Des Fleurs Magiques Bourdonnaient

"I fiori magici ronzavano" conferma quanto i modenesi siano a tutti gli effetti il prodotto più consapevolmente e metodicamente shoegaze mai transitato sulla Penisola. Rumore che non nasce dalle canzoni, ma canzoni che nascono dal rumore: psichedelia totale (che tuttavia talvolta non rinuncia a un certo scenografismo col ricorso a sitar e tremoli ipnotici), texture sonora che impedisce di distinguere nettamente gli strumenti, voci totalmente intangibili. Se per altri progetti italiani si può parlare di contaminazioni o addirittura crossover, qui l'approccio è praticamente enciclopedico e in ogni singola traccia del disco si può riascoltare una voce a caso dal lungo dizionario storico del movimento (con qualche eccezione, come A Ring without an End che sconfina nello stoner di Gardenia). Un'idea così revivalista da un lato infervorava facilmente i cultori del genere, ancora oggi incuriositi dalle potenzialità inespresse dal sound dei mbv, dall'altro si ripiegava troppo su sè stessa per generare un filone nuovo e indipendente.
(2016) Stella Diana - Nitocris

Il quinto album del trio napoletano, al pari dei Rev Rev Rev, è piuttosto emblematico del deserto sonoro in cui vagava la scena (se come tale si poteva riconoscere) gaze italiana di quel momento: se oltreconfine, escludendo lo sterile e fugace ritorno dei MBV, iniziava ad affiorare una nuova via ai riverberi con band come Nothing, Whirr, Title Fight o Pinkshinyultrablast, il filone italiano era vincolato, stante l'assenza di riferimenti a lui vicini, alle scelte più retrospettive possibili. E così gli Stella Diana, che pur non avevano mai nascosto il loro debole per la new wave, davano alle stampe un disco forse tra i più iconici di quegli anni, ma fuori dal tempo, come se fosse stato prodotto a fine anni '80 negli studi di John Fryer. I richiami sono tutti cronologicamente remoti: Cocteau Twins, Slowdive, Cure, anche un po' di kraut. Il disco è costellato di riferimenti sensuali o misterici (Dedu'n, Aphrodia, Aya Ray), al potere femminile e alla carnalità, richiamati sin dal titolo e dalla copertina, ma a predominare è il senso di gelo e l'inverno nel cuore. È come se il romanticismo decadente di Siberia dei Diaframma incontrasse l'impalpabilità di Just for a Day.
(2016) Klimt 1918 - Sentimentale Jugend

La morte di Klimt nel 1918 segna un po' anche quella della Belle Époque e quindi dello Jugendstil (lo stile giovane), un sogno di ribellione in sintesi, contro le brutture del conformismo e dell'utilitarismo moderno. Una sessantina d'anni dopo, i Sentimentale Jugend, ossia Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) e Christiane F. (sì, quella dello Zoo di Berlino), romanticizzavano la gioventù tragica e autodistruttiva, ricercandone paralleli con la Germania pre-'89. Trent'anni dopo ancora, si arriva a Roma dove tanto lunga fu l'attesa del secondo lavoro dei Klimt (otto anni), quanto evidente il loro glow up. Ricollegandosi a questo background ideologico e con un monolite di 19 brani (in quell'arco di tempo i Klimt, colti da ispirazione incendiaria, scrissero due album poi confluiti in un doppio cd) la band conseguì forse il vero capolavoro della corrente italiana. L'album è un requiem all'innocenza delle illusioni e un manifesto di resistenza armata a una società materialista che spegne ogni idealismo. Abbandonato ogni scenografismo alla U2, la band guarda al post-rock e ai Sigur Ros, affogando le proprie voci in coltri di feedback. Il risultato sono paesaggi sonori che trasudano malinconia da ogni angolo, sin dalla copertina, tra le più esplicative di sempre.
(2017) Tiger! Shit! Tiger! Tiger! - Corners

Qui non siamo immersi in acque pienamente shoegaze, ma solo perchè al power trio folignese non piace restare a galla nello stesso mare. Lo avevano del resto dimostrato già dal primo album, ma questo Corners fa le prove generali per un tuffo più acrobatico in quella piscina di pedaloni e feedback che sarà Bloom. Certo, i capisaldi noise sono onnipresenti, ma le ispirazioni DIIV e Cloud Nothing dimostrano che anche nel Bel Paese ci si iniziava a guardare intorno e non solo indietro al passato. La setlist è composta per lo più da bangers indie e slacker rock, è però con i tremoli di Teen Fever e Sacramento, ad esempio, che la band inizia a cucinare a fuoco lento i muri di suono della miglior tradizione gaze. Se non altro, ciò che veramente distingue il disco da produzioni italiane precedenti è l'approdo a un suono genuinamente garage, che non teme di mostrarsi spettinato o meglio ancora, non ostenti falsa trasandatezza.
(2019) Be Forest - Knocturne

Il trio pesarese, che fino ad allora aveva sfornato due album di glaciale darkwave (che, come abbiamo visto, rappresenta un po' il trend internazionale più inseguito in Italia in quegli anni, se pensiamo a band come Soviet Soviet o anche New Candys), si ripresenta con un capitolo di una solennità fuori scala. Le reminescenze sono sempre '80s (Cure, Siouxsie), ma tutto si dilata in atmosfere ancora più immateriali e sospese, incrociandosi con la ricerca sonora oltreoceano degli Have a Nice Life o dei Grivo. Arma a doppio taglio, il disco scorre tutto come un unico suono con un ritmo da cerimoniale dall'inizio alla fine. Una scelta identitaria che si sposa con una vocazione cinematica: un viaggio esistenziale verso il nulla e l'accettazione del vuoto, "We lost ourselves, we’ve not fear of nothingness". Se la gravità goticheggiante del disco rimane un'elaborazione molto personale, l'impostazione dei Be Forest rappresenta una lezione a tratti decisiva per la formazione di gruppi gaze tuttora attivi in Italia.
(2019) Human Colonies - Cloudchaser and Old Songs

Chiudiamo con un disco che in realtà non è un full lenght, ma un EP di quattro canzoni. Direte: perchè? Essenzialmente perchè è un mio kink personale e poi perchè spiega come a volte il mainstream possa determinare involontariamente la recrudescenza di sonorità sparite dai radar. È così che dischi come Viva la Vida or Death and all his Friends, elevatisi di poco al di sopra della mediocre discografia coldplayana, possono far riscoprire una scena dimentica a intere generazioni. Con ogni probabilità il riferimento non è diretto, ma alle prime schitarrate di Body non ho mai fatto a meno di pensare a quello shoegaze 2.0 rinverdito da b-sides come Chinese Sleep Chant, di tanto in tanto ripostate ai tempi nei vari gruppi facebook specializzati con la domanda "Is it shoegaze?". Il power trio della valtellina propose una delle più fresche rivisitazioni del noise pop-shoegaze del tempo: psichedelico senza diventare stordente, sognante senza scadere nello stucchevole, grintoso senza distorcere troppo i volumi.
(2021) Mondaze - Late Bloom

Chiudo sforando di uno o due anni rispetto a quanto avevo previsto inizialmente per introdurre i Mondaze, probabilmente i primi ad aver colto le potenzialità dei nuovi orientamenti shoegaze oltreconfine (Whirr, Nothing, Slow Crush, Narrow Head, Glare), approdati finalmente in Italia con un prevedibile e scontato decennio di ritardo. Cascate di chitarre distorte, costruzioni melodiche seppellite da droni, titoli composti da una parola - massimo due -: il disco risente verosimilmente della lezione di Sway. La ricerca ora è votata a un caos analgesico, uno spleen granitico che conceda poco o niente alla leziosità slowdiviana, agli eccessi di psichedelia shieldiana e alle claustrofobie post-punk. Tutto suona emozionale, a tratti anche sognante, ma cupo e impenetrabile, come un burbero gentile che ringhia per non mostrarsi fragile.



